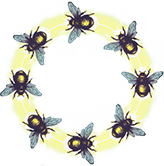Vorrei un mondo senza centri nè periferie – intervista a Maria Reimondez
Nella Roma affollata di turisti in posa, vicino a finti centurioni romani, c’è qualche angolo di buon gusto, come il Papyrus Caffè a pochi passi da Fontana di Trevi. È una piccola libreria che ospita i cataloghi di quattro case editrici (Nutrimenti, Nottetempo, Minimum Fax, Edizioni e/o) e organizza incontri e presentazioni di testi di vario genere tra brunch, aperitivi e sfizi gastronomici.
María Reimóndez mi viene incontro sorridente con una maglietta di Guerrilla girls, su cui c’è scritto che tra i vantaggi dell’essere una donna artista c’è quello di lavorare senza lo stress. Un ottimo biglietto da visita che non smentisce l’immagine che mi ero fatta di lei dopo aver letto il suo ultimo libro di recente tradotto in Italia, “Il club della calzetta” (gran vía edizioni, 286 pagine, 16 euro). Un intreccio di gomitoli e storie dove sei donne sono alle prese con la loro anonima quotidianità e una gran voglia di cambiare, e ci riescono pure. Reimóndez ha tratteggiato sei vite molto diverse tra loro: Matilde, un corpo obeso che la fa sentire a disagio, lavora come domestica e vive con il fantasma di una zia; Anxos ha dedicato la sua vita al partito, militante di sinistra che non si riconosce nella politica fatta dai compagni maschi; Rebeca è bella, troppo bella e perciò ritenuta un guscio vuoto da molti, non è compresa neanche dal suo fidanzato; Elvira ha settant’anni, la maggior parte dei quali trascorsi in chiesa, avrebbe fatto il prete ma non è bigotta; Lux fa la prostituta, per volere della madre, forse per questo non si fida di nessuno; Fernanda ha un marito innamorato di lei, le manca una gamba e sogna di guidare l’autobus.
Con una scrittura limpida e ironica Reimóndez è riuscita a costruire un romanzo che sovverte i luoghi comuni e con leggerezza riflette su questioni cruciali.
Non era facile, ma la giovane scrittrice gallega, nata a Lugo nel 1975, ha chiaro il suo punto di vista sul mondo e ha scelto di esprimerlo giocando con le parole, lavorandoci a tutto campo come scrittrice ma anche come traduttrice e interprete professionista. “Scrivevo molto anche da piccola, avevo un quaderno di poesie e leggevo tanto – spiega l’autrice – “è un modo per comunicare all’esterno il mio essere donna, ma è anche una maniera per intervenire nel mondo: il linguaggio è la forma che sento più comoda, più vicina a me”.
Nel tuo romanzo, le sei donne si incontrano e si raccontato l’una all’altra lavorando a maglia. È uno di quei testi che potrebbe essere definito di letteratura “al femminile”. Sei d’accordo con questa definizione?
No, non mi piace la definizione “femminile”. Quando si usa questo termine, o letteratura di donne, in realtà non diciamo nulla, è un termine vuoto che non fa che aumentare il senso di minorità: dire romanzo femminile e come dire “è cosa per donne”. Rimanda anche ad una contrapposizione che non esiste, mica diciamo “letteratura maschile”, si usa il termine neutro per tutta. La mia è letteratura femminista perché parto da questo mio punto di vista critico sull’esistente.
Le sei donne hanno in comune la necessità di trovare meccanismi di resistenza alla nostra società maschilista, tutte mettono insieme una certa radicalità e anche strategie in qualche modo di sottrazione, come nel caso di Anxos che è la militante del gruppo. Altre alternative non ce ne sono?
Dipende dalle situazioni, nel caso della politica c’è indubbiamente un conflitto per le donne femministe in ambienti misti, perché in genere si hanno ruoli secondari e il potere resta in gestione agli uomini. Lo spazio riservato alla politica femminista è sempre piccolo. Nei partiti è difficile anche solo parlare delle tematiche che riguardano la vita delle donne.
L’alternativa è solo quella di partecipare alla vita della società, ma non si partecipa solo militando in partiti politici o in presunti spazi politici. Io credo molto negli spazi privati, come appunto può essere il club della calzetta. Luoghi che non sono considerati politici in senso ufficiale dalla società patriarcale, ma dove invece ci può essere trasformazione di sé e del mondo.
Hai dedicato questo libro “a tutte le donne che, di fronte a tanta violenza, non reagiscono con violenza”. Immagino ti sei ispirata anche a fatti di cronaca, qual è la situazione in Spagna con la nuova legge?
Indipendentemente dalla cronaca il problema della violenza è strutturale. Ricordo che in Spagna è emerso in tutta la sua enormità quando alcuni anni fa in un reality show una donna disse che veniva da tempo maltrattata, poi tornò a casa e morì a causa di questo. Fino ad allora in Spagna non si faceva differenza tra morti normali e morti di genere. Ossia c’era un conto unico di tutte le morti, e soprattutto non c’era riflessione sul perché accadeva questo. È stato sicuramente importante il processo che ha coinvolto gruppi femministi nella ideazione e stesura della nuova legge, ma poi le norme vengono spesso applicate da uomini o donne che sono parte integrante della società patriarcale. Se non cambia l’approccio culturale, la legge può restare lettera morta.
Che ruolo hanno le femministe in Spagna e che rapporto hanno con le istituzioni?
Se ti definisci femminista sei presa come una pazza, questo è sicuro. Esiste un movimento abbastanza forte in Spagna ma sicuramente minoritario. La società resta sessista, come ovunque del resto. È lo stesso sessismo che ritrovo anche in società apparentemente diverse dalla nostra. Credo che ci sia un problema con le donne più giovani, è come se si fossero fermate, non c’è continuità con quello che è stato raggiunto prima dai precedenti movimenti femministi. Quanto al rapporto tra femministe e potere, direi che ce n’è poco. Noi nel governo in Galizia ad esempio abbiamo Carmen Adan, che è certamente nota come femminista, ma nel governo nazionale c’è poco riscontro.
Sei stata tradotta in Italia in una collana che si chiama “narrativa dalla spagna plurale”. Per la tua esperienza che significa vivere in un paese plurale? È davvero così, c’è reale convivenza?
No, non c’è reale pluralità. Se parlo in gallego può essere un grosso problema. Già questo dà la misura che è un problema politicamente non risolto. Il mio libro è stato tradotto prima in italiano che in spagnolo, solo per fare un esempio. Noi “minoranze” siamo invisibili, se scrivo o parlo in gallego, basco o catalano non vengo considerata. Vorrei un mondo senza centri né periferie, dove non sia un problema parlare una lingua diversa.
La scelta di scrivere in gallego è una presa di posizione politica?
Sì, è un atto politico ma anche coerenza con il mio modo di essere, perché scrivo prima di tutto per le persone che hanno la mia stessa cultura, che sono prossime a me. Del resto non possiamo pensare di cambiare il mondo se prima non cambiamo la nostra cultura. Quindi prima di tutto esprimo il mio punto di vista a chi parla e comprende la mia lingua e cultura.
L’ultimo capitolo si intitola “maglione” che allude a qualcosa di concluso, in realtà poi non c’è un vero e proprio finale. Volevi lanciare un messaggio o era nell’ordine naturale della scrittura che questa trama restasse aperta?
Non volevo un finale tradizionale perché le vite continuano anche dopo che ne hai raccontato una parte, a me interessava la trasformazione delle loro vite senza violenza. Quando le donne trasgrediscono o si ribellano ai ruoli prestabiliti spesso vengono punite o ci sono epiloghi tragici. È una aspettativa patriarcale che ci sia un finale di un certo tipo, invece è reale quello che accade nel libro: le donne cambiano loro stesse, e di rimando il mondo che le circonda, in maniera differente da come si vorrebbe. E ovviamente volevo mettere l’accento sulle relazioni, la solidarietà che può esserci tra alcune donne
Hai fondato una ong che si chiama “implicadas/os no desenvolvemento” (implicati/e nello sviluppo, n.d.r.). Di cosa vi occupate?
È attiva dal 1998, è una associazione mista ma il gruppo dirigente è di sole donne. Ci finanziamo con le quote dei soci e con il contributo pubblico attraverso i progetti che presentiamo. Ci tengo a dire che non abbiamo un approccio “umanitario/caritatevole”, il nostro è un intervento politico perché pensiamo che la povertà sia un fatto politico. Abbiamo dei progetti per il superamento delle discriminazioni di genere in India ed Etiopia, ma facciamo molte attività in Galizia per far capire alle persone come un paese ricco produce povertà altrove. E vorremmo che la Galizia si ponesse in maniera differente rispetto al mondo, lavoriamo perché ciò accada.
pubblicato su Liberazione, www.liberazione.it