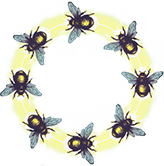«Di Indie ce ne sono molte. Ve ne racconto un frammento» – Intervista a Giuseppe Cederna
Giuseppe Cederna, attore di cinema e teatro, ci ha accolto sorridente nella sua casa romana. Gli abbiamo chiesto di raccontarci l’India che ha conosciuto e amato, tanto da scriverci un libro che uscirà in primavera per Feltrinelli. Le sue parole e il suo entusiasmo ci hanno portato lontano: sembrava di non essere più nel cuore di Roma, ma alle pendici dell’Himalaya, dove lui è stato anche quest’anno.
Il viaggio è un elemento importante nella tua biografia e vita professionale. Perché ora hai scelto l’India, e perché hai deciso di visitare il centro di Vandana Shiva?
Come capita spesso nei viaggi, si è trattato di un caso e di un insieme di coincidenze. Nel ’99, con alcuni amici, abbiamo deciso di andare a visitare le sorgenti del Gange, alle pendici delle montagne himalayane. Siamo arrivati nello stato di Uttaranchal, a Dehra Dun, che si raggiunge con una notte di treno da Nuova Delhi, una valle ricca di piantagioni di riso basmati, orzo, miglio, manghi.
È molto fertile, perché sta alla fine della grande pianura indo-gangetica. Lì la terra comincia a rialzarsi, a muoversi, tante colline e alture diventano il primo zoccolo dell’Himalaya. Non conoscevo quella zona dell’India, ero andato lì attratto da Kipling, dalla mia passione per le montagne, perché i miei bisnonni sono valtellinesi. Volevo andare sulle orme di Kim, in un luogo di passaggio e di scambio, di mercati, di pellegrini e di eserciti. Dove milioni di persone legano la loro vita anche a un atto fisico, culturale e religioso, ma anche laico.
Lì ho pensato che se io fossi stato indiano, alla morte di mia padre sarei andato con mia madre sul Gange per accompagnarlo per l’ultimo viaggio, e lo trovo molto bello.
È stato un viaggio durato a lungo?
No, un viaggio breve, poco più di venti giorni. Ma ne ho scritto per cosi a lungo che ora mi sembra un viaggio nel tempo. Mi ero fatto dare qualche riferimento da Amitav Ghosh, mio amico, forse uno dei maggiori scrittori indiani, e avevo sentito nominare Vandana Shiva. Ma era davvero solo un nome e l’unica cosa che avevo letto di lei era stato un intervento che aveva inviato anni prima a un convegno organizzato dalla Monsanto, dove ovviamente non era andata. Dalle sue parole si capiva che era una donna vulcanica, di grande spessore culturale e forte autorevolezza.
All’invito della multinazionale lei rispondeva che in quel momento si trovava nella sua fattoria nella valle del Doon, Navdanya, che vuol dire nove semi, dove insieme ad altre donne stava classificando e trapiantando centinaia di varietà di semi, riso, orzo e miglio per custodirne e preservarne la biodiversità. Sapevo che era difficile incontrarla, e infatti era dall’altra parte del mondo e sono riuscito a parlare solo con una graziosa e preparatissima «segretaria».
E poi cosa è successo?
È accaduto che il viaggio si è tramutato in una collana di semi, una rete di contatti, di incredibili connessioni.
Siamo arrivati in una cittadina sul corso del Gange, Bhagirathi, dove scopro che da vent’anni è in costruzione una grande diga, la diga di Tehri, conosciuta molto negli anni settanta. Una di quelle lotte un po’ dimenticate, in parte perché persa, in parte perché c’è la diga della Narmada, un dramma sul quale per anni si è concentrata tutta l’attenzione della stampa e dei movimenti.
Mukul, un mio amico di Delhi mi aveva consigliato di parlare con il vecchio lottatore gandhiano Sunderlal Bahguna, che insieme alla moglie ha guidato la protesta. Mi ritrovo in un piccolo villaggio che aspetta di essere sommerso insieme ad altri, per un totale di cento mila persone. Cerco Bahguna ma è partito a piedi per chissà dove e anche lui resta un miraggio, come Vandana Shiva. Tutte le persone che dovevo incontrare sono state sostituite da altri.
E come in altri casi scopro che se la bandiera di questa lotta è lui, il palo che la sostiene è sua moglie Wimla, donna piccolissima, magra, che da anni lavora per l’emancipazione delle donne nei villaggi di montagna ed è decana nella lotta negli hills, ossia le zone collinari prima dell’Himalaya. Mentre lo cerco mi rendo conto anche di quanto la nostra mente sia colonizzata e mi immagino, tipo pubblicità Lipton, di vedere un signore vestito di bianco, dal fare ascetico, di bere con lui un tè molto modesto ma molto indiano, parlando di dighe e di sviluppo compatibile. Niente di tutto questo. Per caso incontro un ragazzino che mi dice che Wimla è al mercato.
Finalmente la incontro, le chiedo se posso intervistarla, lei comincia a parlare e io non capisco niente, sono emozionato, lei parla un inglese sgangheratissimo, mi sento una nullità assoluta, non riesco a scrivere nulla perché mi mancano tutti i riferimenti. So solo che posso e devo raccontarla questa storia: come lei mi guarda, come guarda le altre persone e aspetta che gli altri parlano… E capisco, anche se lei non me lo dirà mai, che la battaglia per fermare la diga di Theri non è persa. È persissima.
Poi mi affida a una persona amica, mi manda nel suo ashram, nel quale lei e Sunderlal Bahguna non tornano da anni. Hanno fato il voto di tornarci solo quando la battaglia della diga sarà vinta. Cioè mai più.
E questo mi fa capire cosa significa il famoso social worker di Gandhi, ossia stare insieme e lavorare nelle comunità ma anche distaccarsene se necessario. Arriviamo in un altro villaggio-comunità che sarà sommerso, ma dove c’è ancora chi resiste.
A proposito delle radici culturali dell’India, come hai vissuto questo senso di comunità, che a noi arriva come uno dei momenti fondanti della società indiana?
Io ho visto solo un frammento dell’India, che è un mosaico incredibile. Quello che posso dire è ciò che più mi ha colpito, ossia il nostro arrivo alle nove di sera in questo villaggio che già dormiva, mentre il nostro accompagnatore-maestro continuava a ridere e parlare, quasi fossimo agenti di un paese straniero arrivati ad aiutarlo. Pian piano la gente si è svegliata e ci ha raggiunto, ci gironzolavano curiosi attorno, mentre una giovane donna, investita d’autorità dall’anziano capo del villaggio, ci raccontava la loro storia. Della loro resistenza nonviolenta, durata anni, al passaggio delle ruspe che volevano buttare giù la roccia da dove sgorga l’acqua pura. Per gli abitanti del villaggio prendere direttamente l’acqua dalla terra è ancora un atto sacro, necessario, e per difenderla si sdraiavano la notte a terra, con i bambini a fare da sentinelle.
Nel buio di quel villaggio ho visto la follia e la cattiveria di una grande diga: non ti torturano, magari se sei fortunato ti danno dei soldi per risarcimento, ma perderai per sempre le tue radici, la memoria, i luoghi fisici e psicologici in cui sei cresciuto. Il senso di collettività. È così che mi sono ritrovato in un viaggio che era turistico, ma sincero, abitato da fantasmi [Vandana Shiva e Sunderlal], ma dove i semi si sono ritrovati lo stesso.
Poi sulla via del ritorno, mi arriva la telefonata che Paola Biocca, una mia cara amica che doveva raggiungerci, si era schiantata con un aereo dell’Onu sulle montagne del Kosovo, il 12 novembre del’99. E allora il viaggio si è trasformato davvero in un pellegrinaggio, in uno straordinario e doloroso rito di accompagnamento della nostra amica nel suo ultimo Grande Viaggio.
Per quello che hai visto, pensi che la società indiana sia stata davvero pervasa dal messaggio gandhiano?
Non saprei dirlo veramente. Certe volte sembra di no, l’India delle città è un paese completamente diverso, «moderno», molto più simile al nostro, dove è difficile capire bene cosa e come le sue radici culturali influenzino profondamente la vita di uno studente o di un operaio.
Una società complessa, in trasformazione. Di cui fa parte per esempio, il mio amico Mukul professore di Storia moderna e storia dei movimenti di liberazione all’Università di Nuova Delhi, impegnatissimo in tutte le battaglie, che andrà al forum mondiale con i suoi studenti e le loro ricerche.
Vive con cinquecento dollari al mese eppure fa molto, poche chiacchiere e tante cose concrete, per esempio una opposizione quotidiana contro i veleni e le violenze del fondamentalismo induista.
Poi arrivi in un villaggio sconosciuto e ovunque si parla di resistenza passiva, che è in realtà attivissima, e dove quello che viene messo in gioco è il proprio corpo. Di fronte a un nemico potente, più forte, forse irraggiungibile, l’unica arma che hai è la difesa delle tue idee, opporre il tuo corpo, mettere tutta la tua vita al servizio di questa cosa. Gli stessi burocrati e ministri, pur tra mille trucchi e calcoli politici, hanno un certo rispetto di questo atteggiamento.
Pensi che questo sia determinato anche dalla cultura indiana, dal cinema, il teatro, la musica?
Nelle grandi città probabilmente sì, nelle comunità di montagna conta molto di più la collettività, più combattiva negli anni settanta. Ora si è perso molto, ma è la storia che va avanti e indietro.
Del resto, io sono figlio di un combattente della collettività, un indignato speciale, decano della lotta alla speculazione edilizia, della difesa degli spazi di verde pubblico, collettivo, di tutti, del vivere civile, di un uomo [Antonio Cederna, ndr] che nonostante i ritardi e le tare della cultura italiana aveva raggiunto dei risultati e ora con questo governo siamo tornati indietro di cinquant’anni. Eppure Antonio avrebbe continuato a lottare anche oggi.
Come le persone che ho incontrato. Mai sconfitte. Anche se hanno perso!
È stata la lezione più bella.
Credi che questo atteggiamento abbia contaminato o possa contaminare i movimenti internazionali, anche in vista del forum mondiale?
A livello morale forse sì, nel senso di essere convinti, quasi geneticamente, di una certa «giustezza»: ossia che l’acqua, i pesci, la terra non appartengono a nessuno, ma a tutti. In India c’è un ecosistema sociale e religioso [perché lì la religione parte dalla vita] che appartiene a tutti.
Loro non possono non pensare che quello è l’unico modo di vivere, anche nelle miserabili periferie delle città.
Per questo è importante che i movimenti non si fermino all’ideologia delle belle parole d’ordine contro le multinazionali. Parole belle, ma subito scariche, inutili. Bisogna sforzarsi di essere più umili, cercare storie concrete, non fermarsi all’apparenza, conoscere bene quello di cui si parla. Partire dalle piccole cose. Questo è rivoluzionario.
E coinvolgere più gente possibile.
Tornando ai tuoi viaggi, i fantasmi poi sono diventati realtà…
Sì sono ritornato, perché scrivendo il libro mi ero accorto che non sapevo ancora molte cose. E allora vado a incontrare finalmente Vandana Shiva, che davvero è una sorta di colonello, un donnone con mille cose da fare, molto distratta, neanche ti vede, intelligente, preparatissima, circondata da persone competenti alle quali ti rimanda per ogni cosa. Lei lavora in un microscopico ufficio illuminato al neon, in un seminterrato che a noi, che siamo un po’ fighetti, fa sicuramente effetto.
Vandana mi ha subito spedito dal botanico mister Bhatt, un suo gentile collaboratore, e con questo giovane «soldato», sono arrivato alla fattoria di Navdanja. E lì ho potuto visitare la cassaforte dei semi. È un piccolo tempio, una stanzetta di terra, paglia e fango pressati assieme, con un’areazione naturale, dove dentro trovi almeno 280 scatole di metallo con tutte le varietà di semi che loro preservano. Un’immagine splendida.
Dopo essere stato lì, sono ritornato a Tehri per incontrare Sunderlal Bahguna, che vive in una miserabile baracca di lamiera, accanto ai cancelli del cantiere della diga, un posto dove d’estate ci sono cinquanta gradi all’ombra e d’inverno un freddo cane. Una coperta, tre libri, un tavolino, e mi è venuta un’illuminazione: tu sei quello che fai, sei quello che vivi ogni giorno.
Sunderlal è un vecchio santo combattente, magrissimo, sdentato, tutto vestito di bianco, parla piano e ride in continuazione, sta lì, guarda il suo fiume che sale e il fango che si accumula, scrive, medita, e compie ogni mattina un rito di deambulazione che mantiene in vita quella che una volta era l’antica capitale di tutta la regione, il Garhwal.
L’acqua stava salendo, il ponte dove ero passato due anni prima era sommerso, tutto il villaggio evacuato e distrutto come fosse un posto di guerra. La diga è un’enorme montagna di sassi che cresce sempre di più.
Abbiamo seguito, i suoi sandali , clip clap, dalle cinque alle sette del mattino, clip clap. Cammina da solo tra le macerie e il fango, pregando e recitando mantra. Alla fine siamo arrivati in cima alla montagna, a un pisciolino d’acqua.
Ha tirato fuori una bottiglia, l’ha riempita e ci ha detto: «Questa è l’acqua che io bevo ogni giorno. Acqua viva, come una volta lo era quella di questo fiume. Madre Ganga. Il fiume che ogni giorno mi insegna ad avere compassione e amore per tutte le cose che vivono e passano».
(pubblicato su Carta n°1/2004, www.carta.org)